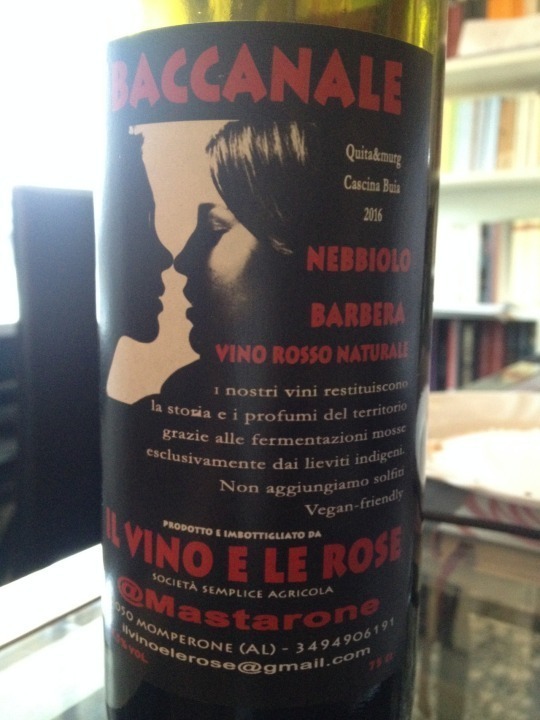Sentii parlare la prima volta di Flavio Roddolo da quell’Enrico Rovera che è stato il mio primo maestro nel mondo dei vini.
Lo considerava il vero prototipo del contadino di Langa.
Quando gli chiedevo dei vini langaroli autentici, mi citava anche altri produttori artigianali -che stimava sommamente, beninteso – ritenendoli, però, intellettuali prestati alle vigne.
Flavio Roddolo era invece l’uomo pragmatico del lavoro manuale e – soprattutto – del silenzio: “Vai da lui”, raccontava divertito l’Enrico, “e subito ti porta sul retro della cantina per mostrarti le vigne. “Lì c’è il nebbiolo” e seguono 30 secondi di silenzio, “lì il dolcetto”, altri 30 secondi di silenzio, “là la Barbera”, ancora un lungo silenzio.”. Roddolo era uno schivo, che non si vedeva nè alle fiere, nè alle premiazioni dei vini.
Ce lo decantò al punto che con Roberto, il mio compagno di scorribande enologiche, decidemmo di andare a visitarlo. Enrico, quando lo seppe, ci raccomandò il Dolcetto: straordinario. Era una dozzina d’anni fa.
Partimmo un sabato invernale, credo: ricordo gli alberi spogli di foglie, il freddo per le vie di Diano d’Alba, dove ci fermammo in trattoria, rimasugli di neve vecchia qua e là.
Direzione Monforte d’Alba, dove non eravamo mai stati. Vi arrivammo da Barolo e superandola verso Roddino, con le colline che diventavano via via più selvagge, mi sembrava di varcare il confine di un mondo remotissimo. Più ancora quando iniziammo, con l’auto che arrancava, la ripida salita che portava alla cantina: un tortuoso serpente nel fitto degli alberi.
Cantina, o piuttosto, visibilmente, casa-cantina, come molte si trovano nelle Langhe: una struttura annosa, di pietra, sobria, con una certa imponenza.
Quando Flavio Roddolo ci aprì la porta, pensai che assomigliava in fondo alla sua casa: un uomo massiccio, ma con una certa grazia impacciata di modi, forse timido, che vestiva una sorta di tuta da lavoro, quasi da operaio. Il viso, incorniciato da barba e baffi grigi, sembrava un’effige risorgimentale.
Si scusò perché era raffreddato: febbricitante nei giorni precedenti, aveva voluto ugualmente accoglierci: una cortesia verso ospiti sconosciuti, che mi intenerì.
Ci fece accomodare. Attraversammo la casa scendendo in cantina. Era scavata nella roccia friabile localmente chiamata tufo (ma credo sia marna), vi si accatastavano ordinatamente innumerevoli barrique. Mi stupii di trovarle da un produttore così tradizionalista e gliene chiesi conto. Ricevetti una candida spiegazione: lavorando da solo, con pochi ettari, gli erano più pratiche da gestire rispetto alle botti grandi; e comunque erano tutti legni molto vecchi, che nulla rilasciavano al vino.
Finalmente giungemmo al portone che dava sul retro. Roddolo l’aprì e dal buio ventre della collina ci trovammo nell’aria fredda su un breve impiantito che dominava dall’alto l’intero bricco, ornato dal fusto spoglio ed enorme di una vite vecchissima, che risaliva gigante le mura della cantina. Pendevano stalattiti di ghiaccio.
La luce era quasi abbagliante, bianca, riflessa di neve, irradiata dai velami di nebbia e di nuvole basse; risalivano ripidissimi i filari vitati, digradanti dalla cima di Bricco Appiani. Lungo di essi scorreva indugiando, infine perdendosi lo sguardo, in un silenzio arcano. Il flebile soffio del vento ed i nostri respiri gli unici suoni. Poi cominciò Roddolo: “Questa è la vigna. Lì c’è il nebbiolo…”, la scena che ci aveva raccontato l’Enrico.
Andammo poi in una sala con un gran tavolone e innumerevoli bottiglie, un po’ chiuse un po’ aperte, e cominciamo ad assaggiare i vini: Dolcetto, Barbera, Nebbiolo, Barolo, Cabernet Sauvignon in purezza; eccellenti: dotati tutti di un grande sussurrato vigore, di una naturalezza confidenziale.
Non ricordo granché della conversazione, ma il tono sì: semplice, domestico, familiare, sussurrato anch’esso. Nè cambiò quando giunse inatteso il giornalista Gigi Garanzini, col quale il vignaiolo aveva evidente confidenza. Roddolo avrebbe potuto guardare noi due, appassionati principianti, dall’alto al basso, lui celebre nella nicchia dei produttori artigiani, apprezzato da firme come Gianni Mura e Andrea Scanzi, e invece era alla mano; avrebbe potuto atteggiarsi da artista iconoclasta, con quel Cabernet che faceva lui, invece diceva solo che nella sua terra gli era sembrato potesse venire bene; poteva proporsi custode integrale della tradizione, invece si serviva spensieratamente delle barrique.
Pensai che quel vignaiolo, da qualcuno descritto come scorbutico, da altri come sempliciotto, era in realtà un uomo acuto che aveva fatto una scelta precisa: nato in quella casa-cantina sulla cima del Bricco Appiani, si era volutamente posto un limite, confinandosi lassù in quella casa, conficcando lui stesso radici nella sua terra, diventando confidente e custode di quel piccolo appartato lembo di mondo, elemento naturale anch’esso, fratello di sangue e destino della vecchia vite che stava sul retro.
Quel limite gli permetteva di ascoltare il silenzio. Nel silenzio c’erano le voci del vento e delle sue viti, che lui intrecciava come un antico polifonista per ricavarne vini.
Sono trascorsi troppi anni: dovremo tornare presto da Roddolo, Roberto e io, appena sarà possibile. Noi avremo qualche capello grigio in capo, che allora non c’era. Lui, forse, qualche ruga in più, ma sarà saldo e vigoroso come quella vecchia vite buona e gigante, sul retro della cantina.
Intanto ce lo ricordano i suo vini: saldi come eroi, hanno il caldo abbraccio degli amici.
Dolcetto d’Alba 2006, 13,5 gradi.
Dolcetto di 14 anni (si dice che i Dolcetto andrebbero consumati nei primi 2-3 anni: questo ha un’età venerabile anche per tipologie più ambiziose).
Non filtrato. Non stabilizzato, se non dal tempo.
Granato profondo, lascia sul vetro gocciole fitte e veloci, di media persistenza.
Ha profumo molto intenso, principalmente di sangue, ferro, ghisa, poi origano, rosmarino, frutta rossa, noce moscata. Cenni farmyard. Ancora in sviluppo. Affascinante.
Soprattutto, però, è vino di bocca.
Naturalezza, anzitutto.
Vivo, virile, elegante, è secco, di corpo medio. Ha avvolgenza glicerica, polpa, sapidità..
L’acidità è giusta da Dolcetto, cioè di medio vigore, ma il vino è ben dritto malgrado gli anni: si sostiene su sapidità vivida e tannino eccellente per presenza, definizione, pastosità e grana.
La trama è ancora fitta e continua fino all’equilibratissimo finale: molto lungo, felicemente amaro e ammandorlato, con la grinta tannica che preme sul palato anteriore: stimolo piacevolissimo, d’altri tempi.
Come una prosa bella e vibrante.
Compagno meraviglioso della tavola, pienamente goduto con salsicce stagionate di Sergio Falaschi, fette di scamone ai ferri, formaggio pecorino.
Barbera d’Alba superiore 2004, 14,5 gradi.
Colore granato tendente al rubino profondo,con lacrime fitte e irregolari. Appare molto più giovane dei suoi sedici anni.
Profumo molto intenso, in divenire, tutto chiaroscuri e prospettive: la delicatezza della rosa, la maturità della fragola e della prugna, la purezza delle erbe amate di montagna, i toni umbratili del tartufo, la sottigliezza degli inchiostri e delle aldeidi.
Sorso molto naturale, polposo, continuo, fluido, lungo, con succo e sale; di corpo notevole, ma fresco per aciditá vividissima, vibrante, perfettamente integrata. Per essere un Barbera ha tannino particolarmente abbondante, ma pastoso.
Nel retrogusto: frutti di bosco.
Vino disarmante: pare sospeso nel tempo e fattosi da sé, senza mano umana né a ingentilirlo, né a complicarlo.
Con amore sulle costine di suino grigio semibrado della Macelleria Falaschi di San Miniato, al forno.